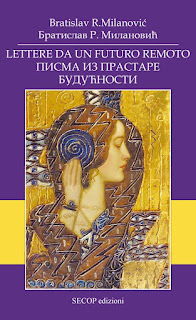Ho creato questo blog perché mi piace incontrare gli altri sul filo della poesia e della scrittura in genere. Ascolto, reciprocità, confronto, comprensione, condivisione...
mercoledì 27 dicembre 2017
I NOSTRI NATALI PASSATI
Con gli anni ho imparato che tutto passa
(passa ogni lama, passa il volo la rondine il pesco fiorito, l'usignolo e il suo canto, l'incanto del primo mattino con la luce che entra nel buio della casa e la rischiara. L'infanzia e la sua fiaba. Passano le stagioni, la neve e la rugiada le nuvole nere il temporale la paura lo spavento. Il tormento d'ogni inganno lo sgomento lo schiaffo il perdono l'urlo il silenzio la furia e la dolcezza. La risata il pianto.
Punto fermo, nel suo eterno movimento, il mare. Culla d’alghe e di onde. Suono di risacca. Tutto passa, lo so, passa la neve e il pianto passa il fiore e la ridente primavera passa l’estate e l’allegria delle onde, il mormorio delle conchiglie all’orecchio e le cinque pietre per giocare e l’autunno con le foglie gialle e il vino nel bicchiere e il fuoco dei tramonti e la tristezza delle scure sere. Tutto passa anche il sorriso su labbra assetate di acqua e libertà).
E sono passati i tanti nostri Natali. È vero, sono passati
(come sono passati gli inverni e i carnevali, l'adolescenza e i primi amori, le primavere e i ciliegi, il mare e i granchi da prendere tra gli scogli di sera e una lanterna per far luce. Come sono passati gli autunni e le foglie tra il vento e le stelle. Le notti insonni e le albe attese. I veli e le malinconie. Le risate al sole e le corse sulla sabbia. Sono passati i giorni della festa e quelli del dolore, i giorni dei progetti e quelli dei rimpianti).
Tutto passa
(e si trascina il tempo che non passa se non sul nostro corpo, arandolo, e tra i capelli, seminando bianchi cespugli invasivi, e sui sentimenti, inaridendoli per troppa siccità e troppa arsura.
Il tempo, una misura relativa, per ciascuno di noi, nel tempo infinito che tutti ci comprende).
Ed è passato anche un altro anno. Tra qualche giorno saremo nel 2018. E ritornano speranze, illusioni, sogni. Ritornano i progetti. Anche il tempo è un eterno ritorno per chi è ancora sotto il cielo e guarda il mistero delle stelle. Il loro incanto.
domenica 24 dicembre 2017
ANCORA SUL NATALE DELLA MIA INFANZIA
Gesù Bambino impiegava molto tempo a nascere. Veniva portato tra le mani-conchiglia del bimbo più piccolo, in testa ad una processione lunghissima che si snodava per tutte le stanze della grande casa (dei miei amatissimi prozii) che aveva un pianterreno, un primo e un secondo piano. Dopo aver salito, sceso, attraversato scale e stanze e camere e ogni più piccolo anfratto della casa e persino i balconi e il terrazzo, si ritornava giù per deporre il Bambino nella grotta tra Maria e Giuseppe, il bue e l'asinello.
La lunga processione si illuminava di candeline bianche o rosse
(spente subito dopo con un brutto odore di cera bruciata e piccoli fili di fumo grigiastro, che si sperdevano ben presto tra le nostre mani giunte e non di rado il bambino più grandicello bruciava i lunghi capelli della bimbetta davanti a lui con grida e soccorsi immediati e scompiglio nella lunga fila e l’acre odore di fumo e di capelli bruciacchiati si spandeva per la casa… che si accendeva delle note divine di “Tu scendi dalle stelle”
(l’immancabile canto tradizionale che includeva voci adulte e bambine e mille inevitabili stonature e approssimate parole…).
Tu scendi dalle stelle, o Re del cieeelo
e vieni in una grott’al freddo e al geeelo
e vieni in una grott’al freddo e al geeelo…
A te che sei del mondo il Creeatoore
mancàno panni e fuocoomio Signooore
mancàno panni e fuocoomio Signooore…
Dopo la nascita di Gesù, noi bambini recitavamo le poesie.
Le donne di casa si affrettavano a preparare la tavola con ogni ben di Dio: pettole, dadini di massa sbollentati, capitone fritto e arrostito (a te e a mamma piaceva molto il capitone, che a noi bambini e ragazzi faceva ribrezzo perché ci sembrava un serpente e basta, e provavamo disgusto nel vedervelo mangiare con tanto gusto…); e, poi, frittelle, cartellate, calzoncelli, mostaccioli, taralli di ogni genere, fichisecchi, mandorle tostate, arance e mandarini, noci e nocelline. Vini e rosolÎ.
Era capitato anche a me di portare Gesù Bambino, ed era capitato a tutti noi bambini di recitare per la prima volta la poesia che zia Maria voleva insegnarci a tutti i costi perché la riteneva bella e facile per i più piccoli che non andavano ancora all'asilo:
Tutti vanno alla capanna
per vedere una gran cosa
anche io son curiosa
di veder che cosa c'è?
Guarda, guarda quel Bambino
come dorme, poverino!
Sembra far la ninnananna
tra le braccia della mamma.
Se io avessi un biscottino,
lo darei a quel Bambino.
Biscottino non ne ho
e il mio cuore gli darò!
Credo che la poesiola abbia attraversato secoli su bocche sdentate di nonne e nipotini e su quelle più morbide delle mamme, prima di giungere sulle labbra di farfalla colorata della mia amatissima prozia e tra le sue mani in volo per mimarla a dovere.
L'ho, poi, insegnata ai miei figli e ai miei nipoti non perché fosse particolarmente bella e facile, come sosteneva zia Maria, ma perché mi riportava a quei Natali, a quell'atmosfera magica e incantata, a quei profumi, a quegli odori, a quelle preghiere, a quei canti, a quelle braccia d'amore. A quei tafferugli. A quelle risate.
Capitava sempre qualche imprevisto, che coglieva di sorpresa la compagnia, creando parapiglia e disagio, risolti immediatamente da qualche battuta ironica o autoironica di zia Maria e tutto finiva in una grande corale fragorosa bolla iridescente di sapone, che aveva forma di labbra dischiuse al buonumore.
Labbra d’infanzia di latte e di panna.
Labbra di bianche perle di giovinezza.
Labbra concave di spietata vecchiaia.
Sì, quella tenera poesiola mi riporta a te, a nonna, a mamma, agli zii e a tutti i parenti e amici di allora. A quei tempi di rumorosa semplicità e di caotica armonia.
Ad un mondo, almeno per noi bimbi, sereno. Un mondo, che oggi esiste solo nella memoria del cuore.
Quel rito si è protratto negli anni quasi intatto.
martedì 19 dicembre 2017
IL NATALE: UN ETERNO RITORNO
Il Natale con te e la nonna mi rimaneva nel cuore senza passare mai. Non tutto passa? Chissà. Anche il Natale è un “eterno ritorno”…
Costruivi ogni anno un presepe grandissimo di carta spessa per le montagne e le vallate, che venivano sovrastate da rami di mandarini con i loro solari frutti. Un profumo inebriante si spandeva per la casa. Tappezzavi, poi, di muschio fresco e odoroso lo spiazzo davanti alla grotta e le stradine che s'inerpicavano fino alle stelle, dipinte su una lunga e larga stoffa di satin blu. E i pastori giganti di terracotta e di cartapesta. E le pecorelle e i cani. E la stella cometa e gli angeli. E un brulichio di luci a rendere magica l'atmosfera dell'Attesa. Il presepe portava in casa prati e montagne. E un senso antico di silenzio e di preghiera.
Durante l'anno, mettevi da parte quelle carte spesse e ruvide, di un colore marroncinoverdemarcio, con cui i negozianti di generi alimentari incartavano i maccheroni, che venivano venduti a peso, sfusi e senza involucro e non a pacchetti da mezzo chilo o da un chilo che, oggi, hanno tanto di etichetta sulla scadenza, che poi magari scopri contraffatta o sostituita per ringiovanire un prodotto scaduto da vari mesi o anni, ma dicono più sicuri (?) dal punto di vista igienico, più belli esteticamente.
Era un presepe grande che occupava una intera parete della sala da pranzo e che completavi, improrogabilmente, entro l'8 dicembre per la festa dell'Immacolata, con lunghi rami di pino ai quali appendevi quei piccoli soli, disseminati tra i verdi aghetti. Quel vellutato tappeto di muschio, dal profumo di terra bagnata, avrebbe agevolato poi il cammino di pastori e re magi verso la grotta. Lucette colorate e la stella cometa, sospesa al filo di nylon invisibile, che andava da una parete all'altra dell'ampia sala.
Il laghetto con le paperelle. La cascata di carta stagnola tagliata a striscioline. Le pecorelle sparse qua e là tra ciuffi d'erba vera e fiocchi di neve finti, di soffice ovatta. E il bue e l'asinello inginocchiati davanti alla mangiatoia con Giuseppe e Maria di terracotta in atto di preghiera. E, in fondo alla grotta, vuoto, il giaciglio dorato in attesa di Gesù Bambino.
Quanto stupore! Quanta soffusa bellezza! Quanto fiduciosa e vibrante quell’Attesa!
In tutta la casa un profumo mai dimenticato e mai più ritrovato di dolcetti natalizi: le cartellate (brune rose di vincotto), i calzoncelli o cuscinetti di Gesù Bambino con pasta di mandorle e cannella, i taralli “inginocchiati” e i tarallini col gileppo, e ciottolini di pasta a ricordarmi d'inverno il mare e il gioco delle cinque pietre sulla spiaggia, i mostaccioli con mandorle, cacao e vincotto, altra delizia di marmorea grazia!
Quel profumo impregnava le stanze e le chiacchiere delle donne che abitavano nel quartiere e venivano ad aiutare mamma e la nonna: Sabellina, Marietta, Angelina. Non si stancavano mai di raccontare fatti e misfatti del vicinato.
Ma il Natale con te era anche bello da vivere perché occupava di sé tutto il mese di dicembre.
Il presepe da far fiorire come un libro dell’Arte Pop-up nei primi otto giorni del mese e, poi, l’Immacolata, Patrona del nostro paese, e il digiuno interrotto la sera della Vigilia con le focaccine della Madonna, formate da pani schiacciati e tagliuzzati in superficie in tanti quadratini e con dentro i semi di anice o di finocchio;
ed ecco Santa Lucia, molto amata e venerata per la sua incrollabile fede
(che porta luce a chi fede non ha).
Dal 16 dicembre, infine, la novena che precedeva il Santo Natale:
Tempo di Attesa e di Preghiera. Tempo di rinnovata Speranza.
Prima della mezzanotte andavamo in chiesa per vedere nascere Gesù Bambino tra preghiere, canti, incenso.
Nella nostra casa nasceva sempre fuori orario: o molto prima o molto dopo.
In chiesa cantavamo insieme con le “signorine della parrocchia”, accompagnate solennemente da un pianista che suonava il maestoso organo, “Tu scendi dalle stelle” e altri canti natalizi…
Non c'erano allora quelli d’importazione americana, “Silent Night”, “White Christmas”, “Jingle Bells” che allietano il nostro Natale nei disincantati giorni dell’attesa.
Né c'era l'albero pieno di luci, di festoni scintillanti con fiocchi argentati, rossi, dorati... Né panettoni in eserciti composti e colorati sugli scaffali dei supermercati. Non c’erano neppure supermercati, ma negozietti alla buona, gestiti alla buona con tanta gente che andava alla buona “con un quadernino” - antesignano dell’attuale taccuino - su cui l’esercente scriveva la somma da pagare appena possibile, nonostante il cartello in bella vista “quì non si fà credensa".
Etichette:
Angela De Leo,
bambini,
blog,
donne,
fiaba,
la poetologa,
Natale
venerdì 15 dicembre 2017
UN TARALLO DI FELICITÀ
Il Natale di tanti anni fa è per me un tempo senza tempo che mi porto nel cuore.
Il ramo di pino con arance e mandarini è ancora oggi un dono di frutti da sbucciare per sentire l'odore intenso delle bucce bruciate nel camino. Un profumo particolare che mi è rimasto dentro. Dentro anche il profumo avvolgente di tutte le pietanze natalizie, mandate al forno di pietra, situato vicino alla nostra chiesa di San Giovanni.
Allora, il garzone veniva a prendere i grandi tegami rettangolari (di non so quale metallo smaltato di nero), con ben allineate lunghe file di rose zuccherine, le cartellate, e li metteva su un'asse di legno scuro; poggiava un “tarallo” di stoffa, che aveva colore di sporco e di fumo, sulla testa e l'asse in bilico sul tarallo e montava in bicicletta esibendosi in larghe piroette di qua e di là, mantenendo miracolosamente la lunga tavola nera in equilibrio perfetto sul capo fino al forno e fischiettando o cantando allegri motivetti. Più una esibizione che una vera necessità: il forno era a due passi. Ma quando passava, noi bambini facevamo “oh!” e lui ci sorrideva, ammiccando felice
(quante storie deve fare se poi cade allora staremo a vedere quali guai combinerà…)
Quanto poco costava un tarallo di felicità!
Ogni volta, però, appena lui svoltava l'angolo e si perdeva alla mia vista, io cominciavo a preoccuparmi per la sorte di quelle delizie che, per fortuna, tornavano sempre a casa, spandendo per le strade un dolcissimo e intensissimo profumo di zucchero filato, vincotto, cannella e chiodi di garofano.
Anche quel profumo mai più dimenticato, mai più ritrovato.
“Basta che un rumore, un odore, già uditi o respirati un tempo, lo siano di nuovo, nel passato e insieme nel presente, reali senza essere attuali, ideali senza essere astratti, perché subito l’essenza permanente e solitamente nascosta delle cose sia liberata e il nostro vero io si svegli”, scriveva Marcel Proust.
Il ramo di pino con arance e mandarini è ancora oggi un dono di frutti da sbucciare per sentire l'odore intenso delle bucce bruciate nel camino. Un profumo particolare che mi è rimasto dentro. Dentro anche il profumo avvolgente di tutte le pietanze natalizie, mandate al forno di pietra, situato vicino alla nostra chiesa di San Giovanni.
Allora, il garzone veniva a prendere i grandi tegami rettangolari (di non so quale metallo smaltato di nero), con ben allineate lunghe file di rose zuccherine, le cartellate, e li metteva su un'asse di legno scuro; poggiava un “tarallo” di stoffa, che aveva colore di sporco e di fumo, sulla testa e l'asse in bilico sul tarallo e montava in bicicletta esibendosi in larghe piroette di qua e di là, mantenendo miracolosamente la lunga tavola nera in equilibrio perfetto sul capo fino al forno e fischiettando o cantando allegri motivetti. Più una esibizione che una vera necessità: il forno era a due passi. Ma quando passava, noi bambini facevamo “oh!” e lui ci sorrideva, ammiccando felice
(quante storie deve fare se poi cade allora staremo a vedere quali guai combinerà…)
Quanto poco costava un tarallo di felicità!
Ogni volta, però, appena lui svoltava l'angolo e si perdeva alla mia vista, io cominciavo a preoccuparmi per la sorte di quelle delizie che, per fortuna, tornavano sempre a casa, spandendo per le strade un dolcissimo e intensissimo profumo di zucchero filato, vincotto, cannella e chiodi di garofano.
Anche quel profumo mai più dimenticato, mai più ritrovato.
“Basta che un rumore, un odore, già uditi o respirati un tempo, lo siano di nuovo, nel passato e insieme nel presente, reali senza essere attuali, ideali senza essere astratti, perché subito l’essenza permanente e solitamente nascosta delle cose sia liberata e il nostro vero io si svegli”, scriveva Marcel Proust.
Etichette:
Angela De Leo,
blog,
la poetologa,
poesia
lunedì 4 dicembre 2017
Ancora una volta Donna
“Sono
nessuno! E tu?
Sei - nessuno
- anche tu?
Siamo in due!
Non dirlo!
Farebbero rumore, sai!”
Così Emily Dickinson.
Per definire la condizione femminile
fino solo a poco più di un secolo fa. Condizione che - come sappiamo - per
molte donne continua ancora oggi. Ma per molte altre, per fortuna, non più.
Il nostro universo troppo a lungo
ignorato dall’altra metà del cielo.
Poi, il riscatto.
In passato, solo qualche voce isolata
faceva sentire il suo canto.
Oggi, è un coro sempre più ampio e
forte e alto e glorioso. Le donne contano e… cantano.
Perché tutti possano sentire.
Ascoltare. Capire.
Le donne valgono.
Ieri facevano la storia dietro le
quinte. Oggi sono la storia.
Graffiano rimorsi. Percorrono strade.
Lasciano orme. Di forza. Di tenerezza. Di poesia.
Anche di Poesia. E tanta.
La donna ha percorsi interiori che
l’uomo ignora.
Ha cieli di emozioni che l’uomo sfiora
appena.
Ha parole per raccontare il proprio
cuore, che l’uomo soffoca e tradisce.
In linea di massima, naturalmente. Non
si possono fare - è chiaro - generalizzazioni.
Ma succede. E spesso avviene proprio
così.
Da Saffo ad Emily Dickinson.
Appunto. E oltre.
Virginia Woolf è la madre di tutte le
donne che scrivono.
A lei dobbiamo il coraggio delle parole
e l’urlo per dirle. A lei, il coraggio dell’attesa e silenzio per ascoltarle.
In quella “stanza” segreta che nessuno
ci può rubare.
Che nessuno può profanare.
Neppure se mille coltelli dovessero
squarciare il sogno dell’alba o l’oro del tramonto.
Il canto di noi donne ha vinto la
notte.
Il buio dei secoli bui …
E la donna …
… Non perderà più le rotte azzurre del
mare. La libertà di osare. Di sognare. Viaggiare … con la mente … con il cuore
… con l’anima …
Di progettare nuovi cieli. Di inventare
nuove storie. Di tentare nuovi percorsi. Di vivere nuovi amori. Di costruire
nuovi e più gratificanti rapporti alla
pari con l’uomo, fianco a fianco, mano nella mano, cuore dentro il cuore. In
due. Con coraggio. Rispetto. Volontà di farcela. Per non essere mai sola. Per
non essere mai solo. Per non essere mai soli.
Il coraggio di reinventare la vita.
È tutto qui il mistero di essere donna,
di essere uomo, oggi: continuare a dare la vita, potendola quotidianamente
reinventare. Potendo quotidianamente reinventarsi.
Per non avere più colpe.
Per non avere più rimorsi.
Per non avere più rimpianti.
Per non avere più nostalgie.
Per non avere più solitudini da raccontarsi.
Da raccontare.
Per avere ogni nuovo domani tra le
mani.
Come foglio bianco ancora tutto da
scrivere. Col gusto di apporvi in calce la propria firma.
(non ho voluto parlare della violenza
sulle donne e del femminicidio. Si è già fatto un gran parlare. Ho cantato,
invece, la sua voce e la sua identità di donna del terzo millennio. Una donna
che può, sa e deve scegliere con chi condividere i suoi giorni).
Etichette:
Angela De Leo,
blog,
donne,
la poetologa
sabato 25 novembre 2017
LE DONNE DELLA MIA INFANZIA
Nel giorno
in cui si parla della violenza contro le donne, mi piace ricordare le donne
della mia infanzia, che mi sono rimaste nel cuore.
Le
ricordo, quasi tutte, molto pratiche e molto sole. Ma anche molto ingenue.
Ignoranti. Analfabete quasi tutte. Non sapevano. E si accontentavano di non
sapere. Quasi fosse normale, giusto così. Erano brave massaie. Semplici. Tristi
o ciarliere e tutte timorate di Dio. Attribuivano a Lui ogni calamità, ogni
malattia, ogni dispiacere. E si rassegnavano alla loro sorte e alla Sua
volontà. Sembrava non avessero ansie né dubbi. Vivevano come respiravano.
Accettavano la vita così come veniva ed anche la loro fede era così come
veniva. Senza ribellioni. Senza ripensamenti.
Ho
molto amato quelle donne semplici, rassegnate, forse anche scontente, forse
anche rancorose, ignare della problematicità dell'esistenza, ma sempre pronte a
portare sulle loro fragili (in apparenza) spalle il mondo, sempre pronte a
farsi un segno di croce per propiziarsi Dio per sé e soprattutto per gli altri,
per scongiurare un pericolo, una malattia, la morte. Sempre pronte a darsi una
mano.
Donne
senza tempo. Senza età. Senza storia. Forse. O, molto più probabilmente, ero io
che non sapevo dare loro un'età, che ignoravo il loro tempo, che fantasticavo
sulle loro per me inesistenti o inconsistenti storie, che sicuramente erano,
invece, storie di lutti, di dolore, di rinunce, sacrifici, silenzi.
Le
loro storie. In realtà, solo apparentemente uguali, ma quanto diverse?
Probabilmente
erano giovani o quantomeno non molto anziane, ma per me erano tutte
irrimediabilmente vecchissime. Nelle loro case vecchissime con i vecchissimi pavimenti
di cemento raramente lavati e travi a vista sotto i soffitti, da cui pendevano
le carte moschicide (non avevano neppure il tempo di scacciare le mosche)
accanto al piatto di vetro plissettato, come una vezzosa gonna, a coprire la
smilza lampadina con fioca luce.
E
sedie impagliate e madie infarinate e santi e morti sul comò e sui comodini con
lampade votive e lumini. E voci di preghiera nella sera.
Andavano
in giro coperte alla bell’e meglio con vecchie sciarpe, sferruzzate con lana
grezza, che ricordavano vecchi corpi e vecchie stagioni di velli di pecore
tosati e di fusi e conocchie tra mani rugose e stanche
(la
bella addormentata con il principe a salvarla era una fiaba da loro ignorata).
E quasi
tutte quelle donne, ricche o povere, giovani o vecchie, erano vestite di nero
per un lutto che non riuscivano mai a dismettere nel cuore e nelle vesti. Tre
anni per la madre o il marito, due per il padre, l’intera vita per un figlio…
Erano
queste le donne della mia infanzia: molte poverissime e analfabete, pochissime
le ricche e istruite. E nessuna proprio nessuna che cantasse mai. Le sentivo
cantare solo in chiesa e dietro le processioni e mai mai in casa o per la strada. Troppa miseria e troppo dolore
per lasciarsi andare al canto.
Le
ho descritte e cantate tutte, sempre, le donne di quel lontano passato.
In
mille modi. In prosa. In poesia.
Le
tante donne della mia infanzia sono ancora qui, in me. Donne che non fanno
storia, che pure hanno vissuto, amato, odiato, riso, pianto, chiacchierato,
ubbidito, ricordato, sperato, pregato. Donne lontanissime nel tempo e a cui
tento di dare una storia perché non si perdano del tutto nel loro tempo.
(Potere
della memoria e della parola scritta. Ma potere anche della fantasia che a
quella memoria aggiunge parole mai dette e vite mai vissute.
La
narrazione fa rivivere il passato e appaga la mia gioia di raccontare…).
“Scrivere vuol dire farsi eco di ciò che non
può cessare di parlare…” (Maurice Blanchot)
Oggi,
è vero, di loro non rimane che un labile ricordo. Diafano. Trasparente. Vago.
Lontano. Incerto.
Rimane
in chi, come me, ha anni addossati agli anni e vive e rivive anche il passato
cercando di riattualizzarlo nella memoria perché non muoia del tutto.
Ma
neppure il ricordo serve a riportarle ai nostri giorni. Sono anacronistiche.
Sono distanti anni-luce dai modelli che le ragazze amano, seguono, contestano.
Sembrano vissute invano e, quindi, non vissute. Si perdono in quella caligine
oscura che il passato trasmette alla mente di chi c’era. Erano solo croci su
croci: una croce, il marito; una croce, i tanti figli nati e altri da mettere
al mondo “come conigli”; una croce, ogni dolore muto, ogni ribellione repressa,
ogni parola ingoiata. Una croce, l’unica identità come firma da apporre sui
rari documenti che affermavano civicamente il loro essere al mondo.
Spreco
di vite
Davvero
inutili? Non voglio crederlo. Non posso crederlo. Distruggerei quella gòmena
d'amore e di rapporti che ha legato e lega le generazioni al femminile perché
non si perda la storia dell'umanità.
Per
questo io amo ricordare e raccontare lacerti di storie che la mente mi
restituisce a tratti, e volti e nomi e parole, sottraendoli alla dimenticanza.
Rimpasto
quelle donne per farle rivivere…
(sono brevissimi stralci dei tanti che
riguardano quelle donne tradite dalla storia e vinte da una cultura che le
voleva serve, mentre erano padrone di sé e dei loro giorni per la forza
titanica dimostrata nelle loro case, prive degli uomini andati in guerra, e affollate
di bocche da sfamare per sopravvivere…
brevissimi stralci, dicevo, tratti dal mio libro di prossima
pubblicazione Le piogge e i ciliegi).
Etichette:
Angela De Leo,
blog,
donne,
la poetologa,
violenza
giovedì 23 novembre 2017
LETTERE DA UN FUTURO REMOTO di Bratislav R. Milanovic
Lettere
da un futuro remoto è uno splendido poema
d’amore che già dall’ossimoro molto originale e visionario del
titolo cattura il lettore perché gli fa scoprire che esiste,
nell’epoca della posta e-mail e dei velocissimi sincopati sms,
ancora la possibilità magica e un po’ démodé di leggere delle
lettere d’amore, scritte doverosamente “a mano”. Queste, poi,
hanno un altro pregio in più: sono scritte sotto forma di poesia.
Sono
lettere che giungono alla probabile persona amata da “un futuro
remoto”.
Dunque,
non sono mai state scritte? Non sono state mai inviate? Vivono in un
mondo altro, dove passato presente futuro si uniscono in un sol
punto?
Si nutrono
di speranza in un futuro migliore del mondo attuale? Cantano una
nostalgia che viene dal tempo ancora irrealizzato?
Forse
tutto questo e altro ancora…
Intanto,
occorre precisare che l’eccezionale autore, Bratislav R.
Milanovic, non ha lasciato nulla al caso: ha suddiviso il suo poema
in tre sezioni dai titoli molto suggestivi: “Del ritorno”,
“Dell’inquietudine”, “Del sogno”. E “Sussurro”, che è
un intenso e originalissimo compendio alla tre sezioni, in quanto
riprende, una per una, le trenta poesie che le compongono e le
ripropone in una sintesi molto particolare in cui l’anaforico
ripetersi di alcuni versi, che sostanziano ogni poesia, crea nel
lettore una visione d’insieme circolare e suggestiva di tutta la
storia narrata.
Una
storia che si distende lungo l’arco degli ultimi trent’anni, dal
1976 ai nostri giorni, in cui il poeta invia alla sua donna ideale
una lettera per ogni anno trascorso, incasellandola nelle dieci che
compongono ogni singola sezione. Quasi una simmetria dantesca, in
formato ridotto.
Sono
lettere d’amore dedicate ad una donna che probabilmente riassume in
sé tutte le donne amate dal poeta in una sintesi fantastica e
immaginifica di caratteristiche più psicologiche e comportamentali
che fisiche, che trovano il loro culmine nella meravigliosa allegria
che fa di questa musa ispiratrice una donna dal sorriso acceso,
splendente di mille colori, frizzante, tenera, audace, altera,
continuamente cangiante nella unicità della sua persona.
Indimenticabile. Una donna che vive nel disordine creativo delle sue
matite, dei suoi colori, pennelli e acquerelli con cui ha dipinto nel
tempo il suo amato, “vivisezionandolo” e ricomponendolo in
migliaia di immagini i suoi innumerevoli
volti.
Bratislav
Milanovic compie il prodigio di vivere, come avvolto e riavvolto, in
una storia d’amore indimenticabile, indimenticata, su piani
diversi, reali e irreali, tra una vita che sembra vissuta nell’al
di là, tra le nuvole e le stelle, nel mistero del silenzio o di una
musica celestiale, e la concretezza di dimore reali abitate in una
Venezia affascinante di artistica suggestione romantica tra
“merletti”,
“vitrages”e
“boudoirs”, o
sulle rive del sonnolento Danubio, dove i gabbiani hanno nido.
L’amata è “laggiù”, in un luogo indeterminato che può essere
semplicemente la terra in una vita ancora terrena oppure Vraciar, il
quartiere tanto amato di Belgrado, o nelle gallerie che si colmano
dei suoi capolavori di pittrice o negli innumerevoli luoghi della
mente del poeta, in debito col vino, dove lei alberga sovrana e rende
la passione più vigorosa e imperitura: “Laggiù,
da te, la passione è ancora passione”.
E i
versi, sempre liberi e insolitamente dimentichi della rima, come è
quasi sempre costume nella poesia serba (ulteriore motivo di
originalità dell’opera, molto vicina al gusto occidentale della
poesia contemporanea), ora si distendono, allungandosi all’infinito
su un sentimento che va oltre la fisicità, lo spazio e il tempo; ora
si contraggono in un dolore che non ha voce né respiro; ora si
rannicchiano nel timore che il sogno svanisca; ora si flettono in una
laica e inascoltata preghiera. Con segni d’interpunzione inusitati
o poco frequenti nel normale linguaggio poetico; con metafore ardite
e visionarie; con gli enjembement che dilatano il senso delle parole
in un “continuum” senza soluzione di continuità; con i versi in
corsivo che ripropongono una condizione di vita nostalgica, se
ripropone un passato che non esiste o che non può tornare.
E
anche gli spazi tra i versi hanno un significato, un senso. Una
direzione. Una voce. E l’ottobre si fa metaforico tempo di un
autunno che abbraccia anni già vissuti e si veste dei colori caldi
delle foglie che rosseggiano, dell’ineluttabilità dello scorrere
delle stagioni della vita fino alla dolcezza dei malinconici
tramonti.
Il poeta,
perciò, nell’autunno della sua vita osa il bilancio di un percorso
esistenziale e si accorge che, tutto sommato, nonostante il paventato
naufragio di sé in un mondo che segna il rovinoso precipitare di
tutti gli ideali, la vita gli ha regalato tanto: il sogno, la poesia,
la forza d’amare.
E, del
resto, egli crede ancora nel potere salvifico della parola e
soprattutto della poesia. Nutre ancora la speranza di poter sognare.
Di saper sognare. Di voler sognare. Perché niente nel tempo si perde
mai del tutto. Se si ripercorrono le vie del cuore. Capaci sempre di
far germogliare fiori. Di donare frutti. Di sostanziarsi di nuova
materica realtà, pur “desiderando” l’eternità delle vie che
attraversano il cielo.
domenica 19 novembre 2017
UN FILO ROSSO, SOLO UN FILO DI LANA ROSSO
Filo
è una parola breve, che dà subito l’idea del suo essere sottile, quasi di poco
conto, di scarsa durata e di cui si può fare anche a meno. E, invece, è di una
incredibile utilità. Serve. A cucire due lembi di stoffa separati ma
combacianti; a legare tanti steli di fiori per farne un bouquet; a ricamare
lenzuola da sposa e tovaglie per i giorni di festa; a stringere altri fili o
tutto quello che va messo insieme e tenuto ben unito. Il filo regge un
palloncino o un aquilone. Se è di perle, diventa ornamento. Se è di olio, diventa
nutrimento. Se è di parole, diventa discorso. Se è colorato, diventa segno di
confine. Se è di sangue, diventa incidente, malessere, timore, paura. Se è di
corrente, diventa luce. Se è del telefono, diventa comunicazione a distanza. Se
è di lana, diventa un maglione o un cappellino. Se è un rossetto, diventa un
papavero sulle labbra e accende un sorriso. Se è sospeso tra due muri, diventa stendipanni
con tante nuvole bianche prigioniere di mollette quasi becchi affamati di
uccelli senza volo; se si tende su case e vallate, diventa l’ardimento del
funambolo che cammina sul filo del suo
sogno…
Ma il
filo può anche legare due polsi e unire due persone, due pensieri, due cuori,
due sentimenti, due percorsi di vita in uno. Ed è bello pensare che un esile
filo possa diventare così resistente da legare due vite, con tutto quello che
in una vita è compreso, moltiplicato due o anche dieci cento mille volte.
Basta
un filo e sembra quasi che si possa andare alla conquista del mondo: del cielo
e della terra, del gioco di un bambino, del lavoro di un adulto.
Ma il
filo, se è di semplice cotone o di preziosa seta, può anche spezzarsi e
riannodarsi. Nel primo caso, separa ciò che aveva unito; nel secondo, ripropone
la cucitura, il ricamo fiorito di bianco o di innumerevoli colori, il legame tra
due o più persone e lo rafforza perché offre, a chi lo possiede e ne fa uso, la
consapevolezza della precarietà della sua consistenza e resistenza, sollecitando
all’attenzione e alla cura per salvaguardare la sua forza, la sua generosa
solidarietà.
Se si
spezza, è importante ricorrere al nodo.
E il
nodo può essere un legame più forte, ma anche un ostacolo. Una promessa o solo un
ricordo. Diventa la misura del tempo e dello spazio. O il punto fermo.
Se,
poi, è anche rosso, diventa dialogo, filo diretto, che crea consuetudine,
intimità, riconoscimento, amore, allegria. Ma anche errore di poco conto,
peccato veniale o, piuttosto, ferita.
Se,
infine, è di lana ed è rosso, allora diventa inequivocabilmente il libro “Un
filo di lana rosso” di Raffaella Leone per i tipi della Secop Edizioni con
illustrazioni di Massimiliano Di Lauro.
E il
libro di Raffaella Leone è un racconto lungo che si dipana in un percorso che
dalla Puglia porta a Milano e ritorno, legando due polsi in fuga, che si
attraggono e si respingono senza tregua e senza sosta, perché sono uniti non
solo da quel filo di lana che si spezza e viene riannodato, ma da un sentimento
d’amore che lega quasi novant’anni di vite, l’una nell’altra; di gioco,
confidenze, voglia di libertà e rifugio sicuro del cuore perché non c’è
distanza che tenga, né altro divario o dissonanza quando è semplicemente una
storia d’amore indissolubile, oltre ogni possibile apparenza. A raccontare
questa storia affascinante è pur sempre il filo rosso, che segna un limite e la
misura di ogni possibile rapporto umano. Che è, a volte, senza limiti e senza
misure, perché riguarda sentimenti che vivono di vita propria oltre il tempo e
lo spazio anche se si nutrono di tempo (gli anni) e di spazio (la propria casa),
da cui sconfinare aiutati da quel semplice filo, che un’autrice straordinaria ha dipinto di
rosso appassionato come il suo cuore e che sa riannodare continuamente perché
non si spezzino mai i capi e non si disperdano mai quegli amori “unici”, che
hanno profonde radici nell’anima.
E
tutto ricomincia… anche ritornando a
leggere dalla prima pagina il libro perché non se ne perda neppure una parola. Nel
tentativo di scoprirne il senso, la profonda verità.
martedì 14 novembre 2017
ANCORA SUL ROMANZO "LA VIA DELLE VEDOVE"
In attesa di pubblicare il mio nuovo libro,
Le Piogge e i ciliegi, ormai solo da rivedere, mi piace riportare qui alcune
note critiche sul precedente romanzo La via delle vedove, che ha riscosso positivi
apprezzamenti dagli “addetti ai lavori” e dai tanti lettori, che mi hanno
gratificata anche con il loro passa-parola.
Dopo la pregevole recensione del
professor Nicola Pice, ecco quella non meno attenta e dettagliata della docente
Valeria Rossini. A entrambi va il mio grazie.
Il
romanzo “La via delle vedove”, pubblicato dalla Casa editrice Secop, è stato
presentato in diversi circuiti culturali con riscontri assolutamente positivi.
Nel
cominciare il racconto l’autrice evoca la metafora della demolizione,
attraverso la citazione di un pittore tedesco che dà abbrivio al romanzo: «Io
adoro le rovine: quando ci si trova davanti alle macerie significa che si è
anche davanti a un nuovo inizio» (p. 5). Da qui parte un viaggio a ritroso
nella nostra Puglia come un pretesto, fenomenologicamente inteso come
possibilità di tratteggiare un’interpretazione della nostra vita, delle
relazioni significative, dei momenti di felicità e dolore che hanno
attraversato i nostri giorni e che in questa condivisione rendono universale
l’esperienza umana, indipendentemente da chi siamo.
«Ed ecco una storia di tante storie, il cui inizio è un
cumulo di macerie» (p. 5). Una storia di una donna anagraficamente entrata
nella terza età, che in realtà è la sua seconda vita, in cui il passato non
appare più sfocato e le immagini delle persone che ha amato diventano
finalmente nitide, anche nel loro non amore. Eva (prima donna) sta tornando
all’inferno dei suoi venti anni, uguali e diversi dai vostri venti anni, per
riaprire ferite mai rimarginate e abitare la stanza segreta dei suoi fantasmi,
delle colpe proprie e altrui.
Leggendo questo romanzo, può nascere il dubbio che
l’educazione al perdono che la nostra cultura – soprattutto religiosa – ha
sempre considerato la via maestra della convivenza pacifica tra le persone, non
sia sempre praticabile… Il perdono è forse l’alibi dei vigliacchi, e il
vestibolo della rassegnazione. Il nostro Sud è stato ed è ancora srotolato
sulle porte della verità come una tenda omertosa «che tutto nega e tutto
accoglie con bocche cucite oltre il bianco abbagliante delle case» (p. 24).
Case di donne, dominanti in quanto serve più che padrone, rimpicciolite anche
nell’identità, attraverso l’usanza orribile di sostituire con diminutivi
orribili anche nomi bellissimi.
Donne con un unico irrinunciabile dovere: rispettare il
proprio marito ed essergli fedele fino alla morte. Si badi: rispettarlo, non
amarlo.
Le regole implicite che da tempo immemorabile si tramandavano
in silenzio le donne, di madre in figlia, recitavano infatti: «giaci a letto
con tuo marito, fatti montare, sfornagli figli, ma non amarlo perché è il
padrone del tuo corpo, ma del tuo cuore mai» (p. 39). E poi i bambini, che
«andavano puniti sempre e comunque, per farli crescere santi, avvezzi alle
rinunce e ai sacrifici. Dovevano imparare a non chiedere mai; e i maschietti
dovevano trattenere le lacrime ed evitare ogni manifestazione d’affetto,
ritenuta debolezza» (p.57).
Tutto questo in evidente contrasto con le teorie
psicopedagogiche a cui si fa accenno nel testo, che rendono ancora più
inaccettabile la rozza ignoranza di quelle donne, atavicamente infelici,
«mummificate nel loro pseudo dolore e nel loro comportamento sempre uguale,
sempre cupo, quasi obbedissero ad una legge interna di rinuncia alla vita. Alla
sua bellezza. Alla sua armonia. Alla sua leggerezza» (p. 57).
Non meno infelice era l’atmosfera che
caratterizzava l’altro fondamentale ambiente educativo: la scuola, infestata da
un’elevatissima mortalità scolastica. I figli dei meno abbienti erano ancora
esclusi o si autoescludevano perché era convinzione comune che la scuola fosse
una perdita di tempo che sottraeva braccia lavoro alla famiglia.
Non c’era attenzione né giustizia pedagogica per i bambini di
allora, discriminati a scuola come bene ha denunciato Don Milani, invisibili in
famiglia e indegni perfino di essere pianti da morti. Per i bambini piccoli
strappati alla vita nella prima infanzia non era previsto il periodo di lutto
di cui erano prova le vesti nere. Sembrava quasi che questi figli non avessero
diritto di cittadinanza nel cuore della madre. «Eva si chiede ancora come
facessero quelle mamme a ingoiare reiteratamente un dolore così grande. Come
potessero mettere al mondo figli in continuazione anche in sostituzione di
quelli che dal mondo sparivano come palloncini
persi nelle profondità del cielo. Come si poteva sostituire un figlio?»
(p. 95). Niente passava attraverso il cuore, altrimenti non si spiegherebbero i
tanti aborti procurati, taciuti e subito dimenticati.
Per fortuna vennero poi il sessantotto e la rivoluzione
studentesca, «che avrebbero di lì a poco spazzato via tradizione, pregiudizi e
soprattutto la cultura del mazziniano/kantiano “dovere” per inaugurare l’era
della rivendicazione dei “diritti”: della donna, del bambino, degli studenti,
dell’anziano, degli handicappati, di tutti quelli che, in pratica, non avevano
mai avuto diritto di parola fino a quel momento» (p. 106).
Una bella rivincita, tracimata tuttavia poco dopo negli anni
di piombo, di cui Eva ricorda la morte dell’innocenza collettiva e della
ragione individuale, «perché nessuno seppe più chi fosse veramente con la
perdita dell’identità e dell’appartenenza» (p. 109). Restava la vita privata a
farle da specchio.
Restano i segreti inconfessabili delle donne della sua
famiglia, con i loro indecifrabili lati oscuri e il loro «morire senza essere
mai vissute» (p. 183).
C’è un’unica possibilità per Eva. Tornare indietro per andare
avanti, ripercorrendo strade battute e sentieri inesplorati. Ecco allora che la
riconciliazione passa attraverso la riappropriazione nel presente di ciò che
abbiamo tentato di archiviare. Noi siamo il prolungamento della storia della
nostra famiglia e della nostra terra, sia pure con inevitabili trasformazioni,
ripensamenti e ribellioni. Noi siamo il tentativo di fuga da un groviglio di
sentimenti inammissibili sempre in agguato, con cui bisogna prima o poi fare i
conti.
Imparando a restare, e a restituire.
Difficile sapere se la protagonista è Angela De Leo, l’autrice, ma in ogni caso Eva resta la
testimonianza viva e autentica di come si possa essere fino in fondo maestri di parole e vita, nonostante
tutto.
Valeria Rossini
domenica 12 novembre 2017
Sul romanzo "LA VIA DELLE VEDOVE" di Angela De Leo
Una premessa. Il romanzo si apre con una dedica al
Salento, terra di sole, di mare e di vento,
sotto la dedica la riproduzione di un quadro, che si dice incompiuto, ma forse
non lo è: una Controra dell’indimenticato Nicola Parisi, con le case
cubiche ricoperte di un bianco calce che degrada sino a dissolversi, mentre in
primo piano sono ritratte in confidenziale conversazione due donne di nero
vestite, come inchiostrate da una densa oscurità, dai volti volutamente
indefiniti, volti senza volti. Alle loro spalle il tempo sembra dilatarsi per
ricercare e comprendere le cose che più stanno a cuore. Insomma il quadro appare
come un dramma in atto in quel gioco di contrasto bianco-nero e in quel voler
produrre uno stato di malinconica nostalgia. Segue nella pagina successiva una
affermazione di Anselm Kiefer, un pittore tedesco che da bambino amava
divertirsi a giocare con i mattoni delle case bombardate: da un lato le rovine,
dall’altro la convinzione che esse sono un nuovo inizio dopo ogni distruzione.
Di qui il sotterraneo convincimento che serpeggerà nel romanzo che la speranza
non muore mai, essa è una virtù bambina e traccia sicura un cammino vibrante
verso il futuro. E se nei quadri di Kiefer uomini e donne appaiono raramente
come se risucchiati dal passato stesso, e tutto si riempie di tinte cupe e
terrose, crettature e stratificazioni, per Angela De Leo la lezione di Vittorio
Bodini è fondamentale e ci deve essere una ragione se nel campo del prologo
essa decide di riportare alcuni versi tratti dalla poesia “Conosco appena le
mani” contenuta nella silloge Metamor (1962).
Ma se il poeta cantore del nostro Sud sceglie di andar
via dalla sua terra, non sapendosi dare pace, e brucia i suoi ultimi anni in
una condizione di morte attesa come liberazione, a me pare che il romanzo di
Angela sia una risposta, la sua risposta, agli interrogativi di Bodini, ed è
una risposta alla domanda che spesso agita le nostre coscienze: che ne è delle
nostre memorie, dei nostri affetti, delle nostre letture, delle nostre
emozioni? Che ne è? Che ne è stato? E soprattutto qual è il senso di tutta
questa strada percorsa, di tutta questa vita vissuta? No, non possiamo
dimenticare, non vogliamo dimenticare. Così tutto ciò che sembra essere
infinitamente lontano, può tornare ad essere sentito come vicino in quanto
parte del proprio vissuto, che non può raggrumarsi nel terribile vuoto della
dimenticanza, ma occorre risvegliarsi dal sonno della noncuranza e della
indifferenza, occorre saper ricercare il riscatto e non scoprirsi solo esseri
che sentono freddo. E come la mitica via de Angelis per il poeta Bodini è stata
una sorta di microcosmo, una sineddoche del mondo, un antro della memoria, una
dimensione di spazio e condizione di sé e in essa si viene a determinare il
miracolo della scoperta della realtà e della sua esperienza, così la casa di
nonna Sabella diventa per Angela un miscuglio di oggetto e di mito, di realtà e
di fantasia, di presente e di memoria, un insieme che sa di mistero e di
favola, di profonda partecipazione e di disincantata ironia, di tristi
condizioni umane e sociali, di volontà di riscatto e di sogni perduti in una
irredimibile infanzia. Anche se quella casa non esiste più, essa vive nella
nostalgica memoria: è scomparso “il giardino retrostante che un tempo respirava
il giorno con alberi di limoni, fichi, melograni e vasi di fiori, gerani,
begonie, belle di notte, donne in camicia, gigli rossi e bianchi. Sono rimasti
rari cespugli di rose selvatiche a boccioli piccoli di un rosso vivo a formare
macchie di sangue sul bianco di calce dei brandelli di muro. E col giardino
spento è sparito anche l’orto rigoglioso un tempo di piante aromatiche,
basilico, prezzemolo, salvia, rosmarino, alloro e diavulicchi di tutti i tipi,
lunghi, rotondi, a campanella”. Ma questo luogo descritto nel romanzo a me
ricorda quello della casa dei nonni della scrittrice. Come a voler dire che la
cifra stilistica del romanzo non escluderà la dimensione autobiografica e ancor
più la dimensione lirica.
Il romanzo di Angela De Leo, oltre che per l’originalità
della struttura narrativa e per l’abilità di scandagliare a fondo nella psiche
umana, difatti s’impone anche per la densità di uno stile fortemente elaborato
e carico di accenti lirici.
“Era la prima a respirare il mare, a farlo entrare col
suo rumore, col suo odore, col suo colore nel giardino e, dalle finestre
spalancate, nelle stanze e negli occhi, nelle orecchie, nelle narici, nel
cuore. E lei aveva imparato ad amare il mare da quelle finestre spalancate sul
mare, da quell’azzurro che si riverberava sul suo letto, da quella nenia tenera
o spaventosa che riecheggiava nel giardino, mescolandosi al lamento del vento,
alla danza dei rami e delle foglie nelle albe ancora prive di sole o nelle
notti ancora colme di stelle”.
Ed io credo che vada sottolineata la dimensione lirica
che attraversa l’insieme delle tante storie di cui si compone e in cui si
collocano ricordi, legami, emozioni, pensieri, che la memoria riordina per
andare in cerca della propria identità. È così che la vicenda narrata, benché
non rifugga da analisi sociologica e comprenda risvolti psicologici interessanti,
di particolare rilevanza e spessore, da autobiografia si fa biografia
collettiva, da racconto di una vita, che è quella della protagonista, si apre
verso lidi più lontani e ingloba conoscenze più profonde. Il filo rosso, che
collega immagini e volti, emozioni e suoni, stati d’animo sospesi e
inafferrabili, è tenuto sempre sospeso dalla scrittrice, se pur essa sembra
voglia utilizzare la tecnica della Ringkomposition, ovvero la struttura ad
anello, e una volta avvenuto lo spostamento del piano temporale, dal presente
al passato, la mente dell’io-narrante si “perde” nella narrazione del viaggio
della vita alla ricerca di un tempo disperso nella memoria, spesso evocato
attraverso i flussi della coscienza, per un avvertito bisogno di dare senso
alla propria esistenza, magari in cerca di risolvere il suo enigma che poi si
rivelerà foriero di conoscenze e di verità: il segreto aguzzino, che la tiene
in ostaggio “all’inferno dei suoi vent’anni”, diventerà il punto di partenza da
cui ripartire per costruire una nuova strada di libertà di pensiero, di azione,
di sentimenti, emozioni e desideri non solo per se stessa, ma anche per tutte
le donne tenute in ostaggio dai condizionamenti ambientali, familiari,
culturali, religiosi, storici. Insomma “un sogno di luce che nella luce muore”.
Una storia di una donna, dunque, che scorre lungo spazi e tempi differenti, e
si riannoda alla storia delle altre, quelle altre donne a cui spesso la libertà
era stata negata e la forza della marginalità era diventata la sponda della
loro esistenza tutta espansa tra squilibri e ingiustizie, rimorsi e nostalgie.
Sono le donne che affollano la via delle vedove, “donne con abiti neri lunghi
fino alle caviglie, coperte da pesanti calze nere, come tanti corvi neri con
labbra concave su bocche sdentate e parole di pianto e di lamenti, lugubri come
quello degli uccelli nei cimiteri”, “donne che restano impassibili e mute al
funerale dei loro uomini, donne alleate in un unico segreto e nemiche per
quell’unico segreto, donne capaci di tutto perché tutto alimentavano con l’odio
crescente verso uomini ignari e colpevoli; per il loro inconsapevole
maschilismo, perché figli di una cultura retriva e priva di orizzonti più ampi,
per la loro incapacità di guardare negli occhi le loro donne, accontentandosi
di saziarsi dei loro seni e delle loro cosce (…) come innocenti, vittime più
che assassine, si ritenevano dopo ogni aborto vissuto nella complicità estranea
e silenziosa della mammana, che buttava giù le tante gravidanze indesiderate
con il chinino in abbondanza e i ferri per lavorare le calze di lana piantati
nei loro ventri”: sembra una pagina del famoso Ernesto De Martino,
l’antropologo che vedeva la miseria culturale della società meridionale come
specchio di una miseria psicologica determinata a sua volta da condizioni
storico-sociali imposte all’intero Mezzogiorno da un regime di subalternità
plurisecolare. E la conferma che nel romanzo ci sia un’eco evidente del grande
studioso è in questa citazione che sembra voler evocare il titolo dell’opera
sua più nota: “Ed è nel mosaico di un sud baciapile e asfittico, inconsapevole
e rassegnato, che vanno a collocarsi le tessere delle storie consumate nella
“via delle vedove” per poter meglio comprendere il loro senso e significato.
Storie di vesti nere come lutto eterno, soprattutto nei paesi dell’eterno
rimorso”. Sul filo della memoria riaffiorano così i sussulti di orgoglio e il
tenace attaccamento alle tradizioni, la volontà e l’ansia di progettare un
futuro diverso, senza mai smarrirsi. Questo trascorrere del passato si fa misura
dell’anima, e della pioggia battente che diventa metafora di nuovo giorno: “un
giorno di pioggia che lava tutto e tutto rinnova. Fa nascere l’erba e fa
fiorire i prati”, il segno del passaggio dal vecchio al nuovo mondo, “dalla
inconsapevolezza delle vesti nere alla coscienza di sé come donna finalmente
libera da tutti gli oscurantismi e da tutti i pregiudizi”. Il buio dei vicoli
stretti e tortuosi dell’umano esistere può colmarsi di nuovo sole e riempirsi
di nuove speranze e di nuovi sorrisi.
Questa narrazione per frammenti di memoria, che grazie
alla fluidità dei vari pensieri si dispongono ora secondo un ritmo lento, ora
secondo un ritmo più andante se pur sempre lineare, si risolve in un viaggio
dentro un tempo che non c’è più e continuamente si arricchisce di finissime
sensazioni che sono fondamentalmente fuse come note che si giustappongono in
una partitura musicale per creare un’armonia, sia attraverso la evocazione del
paesaggio del Salento con la sua luce, i suoi suoni e respiri, indistinti e
confusi; sia con l’impiego di locuzioni e frasi dialettali che danno una
coloritura più veristica a cose e persone al fine di meglio penetrare nella
loro più intima dimensione.
Un’ultima considerazione. La ricchezza della lingua,
che ha un suo indubbio fascino e si fa luogo in cui avvengono esperienze
significative di conoscenze o di emozioni, la lingua ricca, appunto, spiega
ulteriormente il pregio di questo romanzo. Angela conosce e ama la letteratura,
e ci invita ad amarla. Per noi amare la letteratura significa credere che i
personaggi del libro che stai leggendo sono lì, vivi e parlanti vicino a te,
col loro mondo e i loro problemi, e a me sembra proprio che i personaggi di
questo romanzo siano vividi appunto come vivido è lo stile della scrittrice.
Nicola
Pice
martedì 7 novembre 2017
Sintesi della Prefazione a AL CONFINE DI ME di Nico Mori
…
perché il mare da esplorare è ancora profondo,
anche se lungo e infinito è l’oceano da attraversare (Ilario
Verda).
È
l'oceano, splendida immagine di copertina, che penetra subito con
prepotenza di tempeste e con dolcezza d'azzurro i nostri occhi in un
globo d'acque che circoscrive l'immenso e lo dilata nella sua stessa
immensità (e Dio creò le acque...). E ci folgora di solitudine e di
sogno quella vela bianca, che urla e canta e incanta, fragile e
forte, e si esalta di libertà e di coraggio nel solcare tutti i mari
alla scoperta di tutti gli orizzonti e sapere di sé, se vivere o
naufragare.
Mi piace cominciare così la mia circumnavigazione
intorno al confine/oceano di Nico Mori, un amico che non ha mai
smesso di essere poeta e che sempre e da sempre ha cercato, come
uomo, di scoprire/rivelare le sue verità, consegnandosi, agguerrito
di sogni ed inerme di delusioni, a quel perimetro di spazio/tempo
infinito/finito/indefinito, che segna la linea d’orizzonte (sfumata
e appena visibile all'alba, solo ricordo e nostalgia con le ombre
sempre più fitte della sera) e lo circoscrive: non al centro di sé,
ma alla periferia, in uno spazio/tempo che gli appartiene, ma non è
più suo o non più esclusivamente suo: essere/non essere tra un
“io”, sentito dentro come un grumo di esplosione d’amore, e un
“tu” che è soglia e limite e margine di sé e incontro/scontro
con gli altri.
Il nuovo libro di Nico Mori s’intitola, appunto,
Al confine di me (SECOP edizioni, Corato):
corpo e pelle, il margine, in cui quel grumo di sé è, ma si
disperde nel tormento disperato di “sapersi” esistere nella sua
interezza “dentro” e di scoprirsi, “fuori”, estraneo a sé e
incompreso in un mondo che è anche il suo, ma che è “oltre”.
Che
cosa rende evidente il nostro corpo se non il suo confine, l'istante,
cioè, in cui esso si espone al pericolo di toccare e di essere
toccato, di ferire e di essere ferito? Confine non è, allora, ciò
che divide, ma all'opposto ciò che di noi, dei luoghi che siamo, è
sempre necessariamente con l'altro...
Così il filosofo Massimo Cacciari, definendo il termine
"confine", chiarisce alla perfezione ciò che Nico, undici
anni dopo, ha voluto significare con la sua raccolta di poesie, prose
e "altro".
Al
confine di me è, infatti, il dentro/fuori
che il suo corpo occupa e la sua pelle lambisce in un disagio di sé,
dove non si ritrova e si va a cercare. Perché, oltre il suo stesso
confine, l’Autore, esperto navigante in mare aperto, ricorda, in
uno scrosciare di acque che si fa pericolosa zona d’alte maree, di
gorghi e di tempeste, l'antico esploratore e guerriero, quando i
giorni erano una fila di candele accese/
dorate, calde e vivide (Costantino Kavafis).
Oggi, sfiancato pirata all’assalto delle ultime navi fantasma, a
volte si trascina alla deriva di ogni altro da sé, verso un nuovo
confine di sé da riscoprire, se vuole ancora salvarsi da ogni
possibile naufragio ora che i giorni sono penosa
riga di candele spente (ancora
Kavafis), in I tulipani,
splendida poesia che segna l’ingresso al libro di Nico, dopo la
lettera a sua figlia Manuela che ne è la soglia, il primo varco,
come dono e quasi testamento da lasciarle prima di rimettersi in
viaggio e prendere il largo, ancora una volta, in alto mare. Nico,
nella lettera a sua figlia, si definisce:
Un’anima
che non smetterà mai di andare in cerca di meraviglie, dovunque si
nascondano, quale che sia il prezzo da pagare, anche solo per
osservarle..., e
ciò sta ad indicare che il suo non è un nuovo libro, ma il libro. Testimonianza del
mai sopito amore per la poesia e per la vita, che nella poesia
s'incarna e della poesia si alimenta.
Rischierò
il naufragio… o raggiungerò all’orizzonte l’isola dove vivono
i sogni.
Nico,
orizzonte di sé stesso. Isola di sogni dove l’orizzonte sembra
baciare il cielo, ma dal cielo ogni volta si allontana non appena ci
si avvicina a quella linea ideale che ci permette di scoprire e
riscoprire l’oltre, che non sempre è prodigio e conoscenza, ma più
spesso è vertigine, inganno, delusione e tormento.
Il
tempo ha sospinto le mie vele/ al confine di me/ dove ogni strada si
arresta/ al limite dell’Oltre...
È
la poesia d’inizio, in cui il poeta forse naviga già oltre il “suo
confine”, ma il libro non è una silloge di versi né una raccolta
di racconti o di lettere e annotazioni, ma è di tutto un po’: un
insieme di Nico. Uno zibaldone di leopardiana memoria, inserito nei
nostri giorni e in fuga dai nostri giorni, tra prose, poesie,
lettere, annotazioni, citazioni, appunti, che ne definiscono il
“confine”.
Della
mente? Del cuore? Dell’una e dell’altro insieme?
Forse...
o molto altro di più.
Brevi
pennellate di parole ed ecco che in più, rispetto al suo stesso
confine, scopriamo un centro di sé bellissimo e colorato, fatto
dell'azzurro della tenerezza e del rosso della passione e
dell'amaranto di un amore dolce-amaro e del giallo dell'ammirazione
luminosa e dello smeraldo che è armonia e speranza. Brevi ceselli di
versi e l'arte meravigliosa di far fiorire un corpo di donna, un
sorriso di miele, un ricamo di vibranti emozioni. Queste le prose.
Questi i versi di Nico.
Per
riprendere i voli alti dei suoi incanti infiniti con una nuova
consolante certezza a fargli compagnia: gli è accanto Colui che
tutto rimargina, tutto comprende, tutto dona.
E
ha tramutato il Nulla
che avvertiva dentro da molto, troppo, tempo nell'Immenso
della sua
anima, essendo ancora pescatore
di sogni... Per "vivere"
di nuovo e sempre POESIA.
Con POESIA.
lunedì 16 ottobre 2017
Malinconia d’autunno (da "Il vento il fuoco e le azzurre acque")
Arance
castagne melograni
in forma di
foglie danzano
volano
sognano girandolano
con lento
vortice di vento
al
pulviscolo dorato
del
frammentato sole d’ottobre
Lacrima
mestizia
agli occhi
della siepe ingiallita
un autunno
che ha
sapore di ricordi
e si perde
nelle brume mattutine
ancora
calde di progetti residui
Sorpresa e
pentimento
ignorare
nelle mie stanze di fatica
questo
cielo ancora terso ai lucernari
corrucciato
stanco rossastro
ma
inviolato ancora
da nuvole e
piogge e albe di brina
che
s’affacceranno ai freddi cieli
d’inverno
dopo tanta arsura
e un
grondare di sogni feriti
nel
grigiore
di uno
spleen simile al pianto
(anche noi
si sta
in attesa
pavida dell’ultima stagione)
Etichette:
Angela De Leo,
blog,
la poetologa,
libro,
poesia,
Serbia
venerdì 13 ottobre 2017
SINTESI DELLA PREFAZIONE a IL GIOCO DEGLI ANGELI di LJILJANA HABJANOVIC DJUROVIC
Sono
in partenza per la Serbia. A Belgrado devo presentare la mia nuova
raccolta di poesie Il vento il fuoco e le azzurre acque,
tradotto da Dragan Mraovic e pubblicato dall'Associazione degli
Scrittori Serbi. A Belgrado incontrerò i miei amici scrittori e
poeti di lungo percorso letterario insieme. Sono felicissima di
tornare a riabbracciarli nella loro patria che sento anche come mia
seconda patria. Tante affinità e tanto affetto ci legano.
Per
questo, desidero fare un omaggio alla mia amica Ljiljana Habjanovic
Djurovic, postando qui una sintesi del primo suo romanzo, per il
quale ho scritto la Prefazione e ho fatto l'adattamento alla nostra
lingua su traduzione di Dragan Mraovic, altro mio carissimo amico e
grande poeta, scrittore e traduttore serbo.
Ecco
perché, prima ancora di parlare del romanzo, Il gioco degli
angeli, mi piace presentare ai nuovi lettori la sua autrice, la
scrittrice “più amata” in Serbia, la più letta ed apprezzata,
la più premiata, e non soltanto nella sua terra, Ljiljana Habjanovic
Djurovic, perché dovranno a lei le forti emozioni, le insolite
riflessioni, i profondi percorsi interiori, che li accompagneranno
nel loro straordinario viaggio tra le pagine di questo libro. Ljiljana affascina
innanzi tutto con la sua scrittura, caratterizzata da un procedere
molto particolare, attraverso il susseguirsi di frasi spesso lunghe e
ben articolate ma, ancor più spesso, minime, costituite persino da
una sola parola, nel fluire, quasi in continua sospensione, che è
poi una continua puntualizzazione, di pensieri, situazioni, incontri,
scontri tra la protagonista e i numerosi altri personaggi, spesso
co-protagonisti nelle vicende della sua vita. Una scrittura quasi
sempre fratta, dunque, ma proprio per questo molto originale,
suggestiva, catturante, incisiva. Una sola parola spesso racconta il
non detto, il non esplicitato, persino il silenzio, uno stato
d’animo, una illuminazione. La frase breve e brevissima è più
incisiva perché scarna ed essenziale, ma quanto più profonda e
onnicomprensiva della frase dilatata, che rischia di diluire concetti
ed emozioni o il contenuto della storia stessa. Contenuto, che ha le
caratteristiche del romanzo misto di storia e fantasia di manzoniana
memoria, ma anche della più recente connotazione letteraria, che ama
la commistione di vari generi, fusi nell’arte di un nuovo
raccontare ricco di più ampie suggestioni.
Il
romanzo narra la vita di Miliza, la principessa serba del quarto
secolo dopo Cristo, discendente della santa dinastia dei Nemanidi,
che tanta parte ebbe nelle vicende dell’impero serbo nel Medioevo,
e il suo continuo intrecciarsi con l’intervento soprannaturale
degli angeli e soprattutto dell’ Angelo Custode. Ed è proprio
l’Angelo Custode di Miliza la voce narrante: altra originale
peculiarità del romanzo. Ma, accanto a lui, vivono ed intervengono,
con più dettagliati chiarimenti sulla vicenda umana e regale della
protagonista e, in particolar modo, sui compiti delle gerarchie
angeliche, i sette Arcangeli. E tutti e sette hanno una loro
“finestra”, per affacciarsi sul mondo degli uomini e tra i Cieli
di Dio e disquisire di vicende umane e di volontà divina. Insieme,
queste sette voci narranti, creano reiteratamente nel libro una sorta
di coro greco che fa da sfondo a tutta la storia. Non è possibile,
allora, leggere Il gioco degli angeli e non rimanerne
catturati fino all’ultima pagina, per il dipanarsi di questa storia
avvincente, che l’autrice propone con una straordinaria “sapientia
cordis” e con un’abilità letteraria fuori del comune.
Si
tratta di due mondi paralleli, l’uno visibile e reale, l’altro
invisibile e immaginario, ma altrettanto vero nella mente e nel cuore
della scrittrice, che si sfiorano e si contaminano a vicenda.
Nel
romanzo é possibile soprattutto leggere il profondo amore della
scrittrice per il suo Paese: la Serbia, dunque. Ma anche Krusevac,
suo paese natio. Belgrado, nuova meravigliosa capitale. E il Kosovo,
di cui offre uno spaccato di storia tra i più toccanti e veri.
Tutti
i personaggi, inoltre, sembrano scolpiti. Mirabilmente caratterizzati
dall’autrice in tutte le loro peculiarità fisiche, psicologiche,
comportamentali. Ma la eccezionale statura letteraria della
scrittrice si rivela e si evidenzia soprattutto nella sua profonda
capacità di penetrare nel cuore degli uomini e descriverne le
lacerazioni, i contrasti, i chiaroscuri dei pensieri; i desideri e le
rinunce, i rifiuti e le attese, i progetti e le delusioni o le
realizzazioni, i ricordi e le ansie per il futuro, i dubbi e la
ricerca vana della verità e l’incontro con le verità, negli
inevitabili conflitti esistenziali.
L’autrice
racconta in modo mirabile tutto questo, facendo del suo romanzo un
ricamo di storie nella storia, in cui vivono personaggi storici con
tutte le loro ambizioni, passioni, illusioni; con le vittorie e le
sconfitte; con tutto il bagaglio della loro umana esperienza, fatta
per lo più di errori e di pentimenti, di rammarichi e di nostalgie,
nella dolente rappresentazione di una umanità, incapace di vivere il
proprio tempo nella pienezza del presente perché sempre rivolta al
passato o proiettata nel futuro, decretando così il proprio
fallimento e la propria infelicità.
È
probabilmente anche il romanzo del dolore, di una sofferenza
dell’anima che spaventa e fa male, ma è anche il romanzo della
salvezza, grazie alla Grazia divina e, forse, anche agli Angeli
Custodi, che guidano, aiutano nelle scelte, proteggono dalle forze
del male.
È,
pertanto, anche un inno alla preghiera. La preghiera ci redime e ci
salva.
Di qui
l’importanza di un romanzo come questo. Da leggere e da
“mangiare”come “pane quotidiano” per provare a diventare
migliori.
lunedì 9 ottobre 2017
Le Donne rese immortali dall'anima e dalla macchina fotografica di Giovanni Gastel
Ritengo
banale scrivere: “splendida foto per una splendida donna”.
Scontato.
Mi piace, in
realtà, incantarmi a guardare questa Galleria superba della
Femminilità, filtrata attraverso l'anima di Giovanni Gastel e la sua
macchina fotografica. Meraviglioso strumento che tale rimarrebbe se
non prendesse respiro palpitante nelle mani dell'Artista. Mi chiedo:
ma una donna è sempre la stessa donna se viene raccontata da un
uomo? Credo di no. Anzi, ne sono convinta. Siamo due universi
distanti, anche se forse complementari. L'intuito femminile è
diverso dalla razionalità maschile. E, se una donna nota
maggiormente nella luce degli occhi o nella piega delle labbra di
un'altra donna il suo mondo interiore e i suoi misteri, un uomo nota
quel volto nel suo insieme di bellezza fisica o di seduttività. Se,
però, quell'uomo è impastato di sensibilità creativa e poetica,
allora quel volto di donna si fa poesia: ha in sé la luce del divino
che dimora nell'opera d'Arte.
Non tutte le
donne fotografate possono vantare questo soffio, sul loro volto, che
è accadimento e prodigio. A quante sono stati negati la certezza del
volto, lo stupore dell'accadimento? Quante hanno potuto emozionarsi
specchiandosi in una foto ed emozionare lo sguardo di chi le ha
sfiorate oppure osservate?
Con Giovanni
Gastel accade.
E quel volto
o quella figura femminile si trasfigura e diventa altro e altro
ancora: si fa ricciolo di oscuro desiderio, di velluto e sogno, o
cascata di grano nel campo di nessuno; sorriso d'anguria o ombra di
occhi che temono la luce e luce di sguardo che percorre vallate e
sale sui monti e si veste di cielo per riflettersi nel mare e
guadagnare orizzonti mai esplorati. Oppure è corpo che si fa volo e
ali di farfalla, gomitolo di lana o fiore che si dischiude alla vita.
Spavalderia di gambe incrociate, esibite, in attesa, oppure
coraggiose gazzelle, frementi d'avventura nell'andare; e seni
nascosti, svelati, timidi, audaci che invitano mani e occhi e una
passione che pulsa di un attimo appena e poi si spegne come cerino
troppo breve per durare.
Ed è come
scoprirsi in una Galleria buia che a tratti s'illumina di un
bagliore: un lampo, uno squarcio. Un occhio divino su cornici vuote
che le animano. Che si animano. Ed ecco il Volto. Di Donna. Ha due
occhi che feriscono. Buio. Luce. Un altro Volto. Ha labbra-papavero
che accendono il cielo di un sorriso. Buio. Lampo: quella donna non
ha né labbra né occhi, solo un mistero che vuole celare. O svelare
a chi sa leggere e vuole leggere in quel mistero. Buio. Squarcio. E
il nero si fa ala di corvo, notte di rimpianto, urlo di due lacrime
non piante sul pallore del viso. Luna sorpresa di solitudine e
d'abbandono. Poi ecco l'oro di un volto sontuoso nella sua altera
fissità bizantina di icona lontana che veste di preziosa antichità
i monasteri del Kosovo e quello serbo di Kilandari.
Buio. Luce.
Per Donne donne fiore donne erba donne prato donne sogno donne nuvola
donne volo donne mare e maree. Donne svettanti come vittorie a lungo
sognate e rincorse e afferrate. Donne protagoniste di una storia, di
mille storie. E Donne che hanno scritto la storia della Moda,
dell'Arte, del Cinema e del Teatro. Donne integrate nel loro tempo e
spazio vitale o sbalzate come un bassorilievo oltre il tempo e lo
spazio.
Rese
immortali da quel lampo di luce che è talento più che tecnica,
genialità più che immagine, sensibilità più che angolazione di
ombre, amore più che posa o inquadratura.
Giovanni
Gastel, con la sua macchina fotografica, le guarda le donne per
ascoltarle. Le ascolta per conoscerle. Per riconoscerle e
raccontarle. Entrando nella loro anima per vivificarle di una
ineffabilità che solo l'anima possiede.
E le Donne
della sua meravigliosa Galleria si accendono di mille atmosfere, di
luminose essenze, misteriose eppure vicine, in tutte le loro
sfaccettature, quasi fossero in un prisma in cui sanno esse stesse
conoscersi e riconoscersi per colmarsi di pienezza di sé, di
autenticità, di LUCE...
E,
immortalando, Giovanni Gastel si immortala.
Iscriviti a:
Post (Atom)